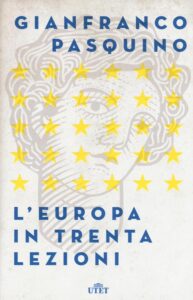
Gianfranco Pasquino – L’Europa in trenta lezioni – Utet, Torino, 1917, p. 173
Un tempo l’Unione Europea non era che un sogno. Confinati dal fascismo sull’isola di Ventotene, tra i bagliori sinistri della guerra mondiale che infuria lontano, Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi scrivono il famoso Manifesto, in cui l’unità dell’Europa è già «una impellente tragica necessità». Oggi l’Unione Europea – a sessant’anni dagli accordi di Roma che diedero vita il 25 marzo 1957 al suo nucleo iniziale, la Comunità Economica Europea – viene considerata da molti suoi cittadini un’istituzione distante e complessa, per non dire complicata e dannosa. Una realtà per pochi e a favore di pochi. Eppure, per il suo ruolo centrale su tutti gli aspetti del vivere comune, l’immigrazione, l’economia, la difesa dei diritti individuali e collettivi e la tutela delle minoranze, è giusto considerarla una risorsa di tutti e che tutti riguarda. A partire da questa consapevolezza, Gianfranco Pasquino ci racconta con passo rapido e ampiezza di sguardo il passato e il presente di questo sogno difficile: trenta limpide lezioni che ricostruiscono gli equilibri di potere su cui si regge, gli organismi di cui è composta, i suoi valoriguida, le personalità che ne hanno influenzato lo sviluppo, le problematiche di ieri e di oggi. Un inedito viaggio nell’“Europa che c’è” e in quella che avrebbe potuto – e potrà – esserci, tra il progetto federalista degli Stati Uniti d’Europa e le brusche frenate degli ultimi anni (la più clamorosa, la Brexit: il referendum che ha sancito l’uscita del Regno Unito dall’UE). L’Europa in trenta lezioni è un’occasione per fare il punto sull’Europa che abbiamo costruito fin qua, nel momento in cui più forti soffiano i venti contrari del populismo e del nazionalismo più ottuso. Un modo per capire cosa rischiamo di perdere e cosa potremmo invece riconquistare, recuperando i valori di libertà, di pace, di prosperità da cui, nelle ore più buie del secolo scorso, è nata l’idea di Europa unita.
Lezione 8:
Altiero Spinelli
Altiero Spinelli (Roma 1907-1986), di famiglia laica, aderisce molto giovane al Partito comunista d’Italia, nel 1924. Fiero combattente antifascista è incarcerato per dieci anni a Viterbo e a Civitavecchia (1927-1937).
Fu inviato al confino, prima a Ponza, dove venne espulso dal Partito comunista per “deviazione ideologica e presunzione piccolo-borghese” (in realtà, per non avere mai nascosto le sue critiche all’accusa di social-fascismo indirizzata ai partiti socialisti e in particolare ai socialdemocratici tedeschi, e per avere espresso riprovazione nei confronti delle epurazioni e dei processi staliniani), poi a Ventotene. Qui, grazie all’amicizia e alla convergenza intellettuale con Ernesto Rossi (1897-1967) ed Eugenio Colorni (1909-1944) matura il suo pensiero federalista che traduce nel Manifesto di Ventotene (1943). Tornato in libertà nell’agosto 1943 dopo la defenestrazione di Mussolini, si impegna in una intensissima campagna di sensibilizzazione e di propaganda federalista. Per temperamento e per scelta ebbe sempre un difficile rapporto con i partiti tranne che con il Partito d’azione, della cui segreteria fece parte per alcuni anni a cominciare dal 1945 e per il quale scrisse i contatti con Saragat, eletto (nel 1964) presidente della Repubblica, e soprattutto con Pietro Nenni, diventato prima vicepresidente del Consiglio e poi ministro degli Esteri (dicembre 1968-agosto 1969), di cui fu apprezzato consulente.
Fu nominato commissario europeo nel luglio 1970 e fino al maggio 1976 si occupò non soltanto delle materie specificamente affidategli – affari industriali, ricerca e sviluppo tecnologico – ma soprattutto della riforma delle istituzioni europee. Il suo progetto di fondo, le cui linee furono approvate quasi un decennio dopo dal Parlamento europeo, consisteva nel fare della Commis-
sione un organismo propulsivo della Comunità; nell’attribuire notevole potere – anche decisionale – al Parlamento europeo, rappresentante e interlocutore dei cittadini; e nel consentire al Consiglio dei capi di Stato e di governo un compito di valutazione e di supervisione delle iniziative prese dalla Commissione. Riuscì a ottenere molto poco di tutto questo, ma, almeno in una certa misura, l’attribuzione del Premio Schuman nel 1974 costituì il meritato riconoscimento che, in pratica, come scritto in una influente pubblicazione europea, Spinelli era rimasto l’ultimo dei federalisti (il più combattivo e il più coerente). Il combattimento continuò nel 1976 con l’accettazione della candidatura al Parlamento europeo, propostagli da alcuni dirigenti suoi coetanei del Partito comunista, che in questo modo rimediavano indirettamente al loro passato settarismo. Venne poi la nomina nella delegazione italiana al Parlamento europeo che, ancora nel 1976, era eletto indirettamente, seguita dall’elezione vera e propria nel primo Parlamento europeo votato dai cittadini nel 1979.
Partendo da un piccolo gruppo ri che s’incontravano nel ristorante “Le crocodile” du Strasburgo, Spinelli elaborò quello che era un progetto di trattato per “una Unione sempre più stretta” e, al tempo stesso, una Costituzione per l’Europa. È opportuno lasciare alle sue parole (citate da Piero Graglia in Altiero Spinelli, Il Mulino, Bologna 2008, p. 603), che sintetizzano una vera e propria “filosofia politica” delle costruzione istituzionale dell’Europa, la descrizione del progetto che sottopose alla votazione dell’Assemblea parlamentare: Il nostro progetto fa della Commissione un vero esecutivo politico, mantiene un ruolo legislativo e di bilancio per il Consiglio dell’Unione, ma lo definisce e lo limita, dà al Parlamento un vero potere legislativo e di bilancio, che esso divide con il Consiglio dell’Unione. Il nostro progetto riconosce l’esistenza di una sfera di problemi che saranno trattati dal Consiglio europeo con il metodo della cooperazione. Ma, da un lato, esso vieta al metodo intergovernativo di invadere il campo dell’azione comune e, da un altro lato, apre una porta che rende possibile il passaggio dalla cooperazione all’azione comune.
Non è, credo, un esercizio sterile quello di andare a cercare i punti di contatto fra i Trattati successivi, fino a quello di Lisbona, e quanto formulato da Spinelli. Però, è probabile che il più grande e il più ostinato federalista italiano preferirebbe un altro procedimento: andare Altiero Spinelli a cercare quello che ancora manca. Parecchio di quello che è stato fatto dopo la sua morte nel 1986 appare, spesso, debitore delle sue formulazioni.
Molto di quello che si dovrà fare avrebbe certamente tratto vantaggio dalla sua energia, dalla sua capacità di coinvolgimento, dalla sua visione, dalla sua passione.
Tutt’altro che priva di una solida architettura istituzionale, l’Europa coerente con il pensiero e con l’azione di Spinelli troverà il suo effettivo compimento soltanto se costruita dai popoli europei e funzionante secondo le più inclusive e incisive procedure democratiche.

 https://www.raiplay.it/video/2025/03/Il-senso-del-sogno—Il-Sogno-Roberto-Benigni-19032025-59a7066e-9fec-4214-b3ce-0699995b8251.html
https://www.raiplay.it/video/2025/03/Il-senso-del-sogno—Il-Sogno-Roberto-Benigni-19032025-59a7066e-9fec-4214-b3ce-0699995b8251.html