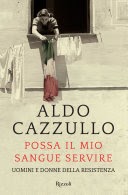Gli anti-fascisti e la guerra persa della memoria, in Italia
di Aldo Cazzullo
Corriere della sera, 29 Marzo 2025
Milioni di italiani non sanno quale tragedia sia stato il fascismo, e non lo vogliono sapere. L’antifascismo è considerato di parte, perché molti pensano, magari in buona fede, che la Resistenza sia stata fatta soltanto dai comunisti, o comunque dalla sinistra. Ma non è vero.
Pubblichiamo un brano della nuova prefazione di Aldo Cazzullo al suo libro del 2015 «Possa il mio sangue servire. Uomini e donne della Resistenza», che Rizzoli ripubblica per l’ottantesimo anniversario del 25 aprile.
In questi trent’anni in Italia si è combattuta una guerra della memoria. E questa guerra noi antifascisti l’abbiamo perduta. Nettamente e clamorosamente.
Non è stata una sconfitta elettorale. Non solo perché le elezioni la sinistra le ha quasi sempre perse. Anche perché solo in Italia — e questo è un altro segno della nostra sconfitta — è passata l’idea per cui se sei antifascista sei comunista, o comunque di sinistra.
Non è così.
Il nazifascismo fu sconfitto da uomini di destra. Un conservatore inglese come Winston Churchill. Un nazionalista francese come Charles de Gaulle. I nazisti, prima ancora di eliminare gli ebrei, gli zingari, gli omosessuali, cominciarono a eliminare i bambini Down. Li chiudevano dentro camion che diventavano primordiali camere a gas. Il programma di eliminazione dei «minorati mentali» fu interrotto grazie all’intervento di un oppositore del regime. Non era un bolscevico; era un vescovo, di famiglia aristocratica. Si chiamava Clemens August Joseph Pius Emanuel Antonius von Galen. Dal pulpito della cattedrale di Münster disse: «Hai tu, ho io, il diritto alla vita soltanto finché noi siamo produttivi, finché siamo ritenuti produttivi da altri? Se si ammette il principio, ora applicato, che l’uomo improduttivo possa essere ucciso, allora guai a tutti noi, quando saremo vecchi e decrepiti… Nessuno è più sicuro della propria vita».
Martin Bormann, il segretario di Hitler, propose: «Impicchiamolo». Non era uno scherzo: i ragazzi della Rosa Bianca, studenti universitari colpevoli di aver distribuito qualche volantino, furono dai nazisti torturati e decapitati (questi erano gli alleati che Mussolini si scelse).
Fu Joseph Goebbels, che conosceva l’arte della propaganda, a obiettare che impiccare un vescovo non era una buona idea. La donna che Charles de Gaulle amò di più nella sua vita era la figlia Anne, affetta dalla sindrome di Down, che spirò a vent’anni tra le sua braccia. Così il Generale e sua moglie, la cattolicissima Yvonne, aprirono un istituto per accogliere e salvare i bambini come quelli che il Fuehrer sopprimeva con il gas.
La scelta tra il nazifascismo e i suoi oppositori non è la scelta tra la destra e la sinistra. È la scelta tra la barbarie e la civiltà.
Eppure questa conclusione, considerata in tutto il mondo un’ovvietà, in Italia è contestata.
Di solito si dice: il problema è che in Italia manca la memoria condivisa.
Vi confesso che alla memoria condivisa non credo. Di memoria ognuno ha la sua, e non la può cambiare. La memoria di chi ha portato gli ebrei italiani ad Auschwitz non può essere la stessa di chi ha lottato contro coloro che portavano gli ebrei italiani ad Auschwitz. Non la memoria, ma i valori dovrebbero essere condivisi. Invece il valore dell’antifascismo è considerato oggi un valore di parte. Una cosa solo di sinistra.
Nulla di più sbagliato. Le prime bande partigiane furono fondate da ufficiali dell’esercito, in particolare da alpini che erano stati in Russia, e dopo essere stati testimoni della guerra di sterminio condotta dai tedeschi avevano tenuto le armi, convinti che prima o poi avrebbero dovuto usarle contro di loro. La maggior parte degli italiani si illusero invece che bastasse concludere l’armistizio con gli angloamericani per uscire indenni dal conflitto. Non avevano capito che, per il regime nazista e il loro criminale capo, la guerra era ormai una questione di vita e di morte; e che l’Italia sarebbe diventata un campo di battaglia, una terra di conquista.
La Resistenza comincia subito dopo l’8 settembre. Comincia a Porta San Paolo e sul ponte della Magliana, dove reparti dell’esercito e uomini del popolo tentano di resistere ai tedeschi. Comincia a Cefalonia, dove il generale Gandin chiede ai suoi uomini di votare — ragazzi di vent’anni che non avevano mai votato in vita loro, che non sapevano neppure cosa volesse dire votare — per decidere se arrendersi ai tedeschi o combatterli. Prevale la decisione di combattere, e all’inizio gli italiani hanno la meglio, poi i bombardamenti della Luftwaffe li costringono alla resa, cui seguono fucilazioni di massa e affondamenti di navi: i caduti sono più di seimila.
La Resistenza prosegue nei campi di concentramento tedeschi. In pochi giorni, i nazisti fanno prigionieri 800 mila soldati italiani. Vengono portati nei lager, spogliati, affamati, umiliati, azzannati dai cani lupo. Poi viene detto loro: ora vi diamo da mangiare, vi forniamo una divisa, vi liberiamo; ma dovete firmare qui e impegnarvi a combattere per noi, per i tedeschi. Oltre seicentomila, la netta maggioranza, risponde di no, e sceglie di restare nei lager in condizioni disumane — almeno sessantamila moriranno di fame e di stenti — pur di non combattere più per Hitler e Mussolini.
Tra loro c’era Alessandro Natta, futuro capo del partito comunista, che solo in tarda età pubblicherà un libro intitolato non a caso «L’altra Resistenza»; e c’era Giovanni Guareschi, anticomunista di ferro, il papà di don Camillo e Peppone, che nel suo diario scrive: «Non muoio neanche se mi ammazzano». C’erano i padri di Francesco Guccini e di Al Bano, di Antonio Di Pietro e di Vasco Rossi, che si chiama così perché il padre Giancarlo stava morendo, in una buca scavata da una bomba americana, quando un compagno lo tirò su di peso: «Come ti chiami? Vasco? Se un giorno avrò un figlio, lo chiamerò come te».
Sono gli internati militari in Germania, e di loro si è sempre parlato molto poco.
Era un internato militare in Germania anche il capitano Giuseppe De Toni, che al fratello scrive di voler restare nel campo di prigionia per «dimostrare che vi sono degli Italiani pronti a sacrificare tutto per un’Italia rispettata, onorata». Lo stesso concetto, quasi le stesse parole che scrive al padre il capitano Franco Balbis, prima di affrontare il plotone d’esecuzione fascista, e che danno il titolo a questo libro: «Possa il mio sangue servire per ricostruire l’unità italiana e per riportare la nostra terra a essere onorata e stimata nel mondo intero».
E anche la data è la stessa: 5 aprile 1944.
Due capitani, due ufficiali italiani che non si sono mai incontrati e mai si incontreranno, perché nessuno dei due sopravvivrà alla guerra ed entrambi daranno la vita per la patria, scrivono la stessa cosa, interpretano la Resistenza come riscatto nazionale e morale, come rinascita politica e umana, dopo la notte e la vergogna nazifascista.
Gli anti-fascisti e la guerra persa della memoria, in Italia
L’edizione aggiornata del libro di Aldo Cazzullo (Rizzoli)
Franco Balbis era un ufficiale dell’esercito. Aveva combattuto la seconda guerra mondiale in Africa. Prima di essere fucilato, lascia scritto di celebrare una messa ogni anno nell’anniversario della battaglia di El Alamein, in memoria dei commilitoni caduti. Il capitano Balbis faceva parte del comitato militare della Resistenza piemontese, catturato dai nazifascisti mentre era riunito non in una fabbrica occupata, non in una sezione del partito comunista, ma nella sacrestia del Duomo di Torino, con il consenso dell’arcivescovo.
Con i militari vengono presi i rappresentanti dei partiti, tra cui un comunista, uno solo: Eusebio Giambone, un amico di Gramsci, operaio della Fiat costretto all’esilio. Anche lui si alza in piedi a gridare «Viva l’Italia!», quando lo ordina il capo del comitato militare, il generale Giuseppe Perotti. Il tenente Silvio Geuna, condannato all’ergastolo, ha offerto la sua vita per salvare quella del generale, condannato a morte. Perotti, che non vuole essere salvato, tronca la discussione gridando: «Signori ufficiali, in piedi!». Gli ufficiali si alzano in piedi. «Viva l’Italia!» grida il generale Perotti. «Viva l’Italia!» rispondono gli alti condannati. Una scena di straordinaria forza morale, di commovente nobiltà d’animo. E io, nel mio piccolissimo, sono orgoglioso di aver pagato un piccolissimo prezzo — essere insultato non solo sui social ma pure sui giornali, pure da illustri accademici, fascisti o ex maoisti convertiti, più le telefonate anonime, le mail di offese, le lettere di minaccia — per aver raccontato storie come questa.
Eppure, sia chiaro, hanno vinto loro. I fascisti, e gli anti-antifascisti. Milioni di italiani che non sanno quale tragedia sia stato il fascismo, e soprattutto non lo vogliono sapere. E pensano, magari in buona fede, che la Resistenza sia stata fatta soltanto dai comunisti, o comunque dalla sinistra.
In realtà, la Resistenza fu un fenomeno plurale. Fu fatta da partigiani di ogni fede politica: comunisti, socialisti, azionisti, anarchici; ma anche moderati, cattolici, liberali, monarchici; e soprattutto ragazzi di vent’anni che non sapevano neppure cosa fosse un partito, ma non volevano più combattere per Hitler o Mussolini.
Erano autonomi dai partiti i comandanti militari della Repubblica dell’Ossola, primo esperimento democratico nell’Italia ancora occupata dai nazisti: Dionigi Superti, napoletano, aviatore della Grande Guerra, e Alfredo Di Dio, palermitano, che cadrà in combattimento il 12 ottobre 1944. Era un autonomo Ernesto Martini «Mauri», che comandava la Resistenza sulle Langhe, e aveva ai suoi ordini il giovane monarchico Beppe Fenoglio. Era un cattolico Ignazio Vian, l’eroe di Boves — il primo paese bruciato dai nazisti —, impiccato a un albero nel centro di Torino.
A gonfiare le bande dei resistenti furono i bandi Graziani, che obbligavano i giovani italiani a combattere dalla parte dei tedeschi. Molti andarono convinti. Molti andarono per paura, qualcuno di loro disertò alla prima occasione. Molti si nascosero: erano renitenti alla leva i fucilati dalla banda Carità in campo di Marte a Firenze, e la maggioranza dei giovani impiccati agli alberi di Bassano del Grappa. Molti salirono in montagna.
La Resistenza però non fu fatta solo dai partigiani, ma anche dai civili, dai contadini che protessero i patrioti, dagli ebrei, dalle donne, dalle suore che nascosero i perseguitati nei conventi, dai sacerdoti. Si parla molto, e giustamente, dei preti fucilati dai partigiani; non si parla mai dei 190 sacerdoti fucilati dai fascisti e dai 120 fucilati dai tedeschi, perché avevano scelto la Resistenza. Sacerdoti che decisero di morire accanto ai fedeli, come don Ferrante Bagiardi: «Vi accompagno io davanti al Signore» disse prima di affrontare il plotone d’esecuzione nazista. O come suor Enrichetta Alfieri, la protettrice dei prigionieri di San Vittore, tra cui Mike Bongiorno e Indro Montanelli, che al processo di beatificazione dichiarò: «Certe cose possono farle solo i santi o gli eroi; e suor Enrichetta era entrambe le cose».
La Resistenza fu fatta anche dai militari. Dai soldati che combatterono al fianco degli Alleati. Dai prigionieri che rifiutarono di andare a Salò. Dai carabinieri deportati a migliaia di Germania. Dai poliziotti che presero le armi per difendere gli ebrei, come Giovanni Palatucci, Angelo De Fiore, Mario Canessa, Mario De Nardis, che sono oggi Giusti tra le Nazioni.
La Resistenza è patrimonio della nazione, non di una fazione.